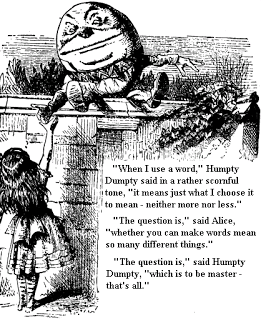Nel dibattito pubblico italiano il tema della violenza, quella politica o politicamente motivata, è andato incontro a un singolare destino: tanto più se ne evocava l’incombenza quanto meno trovava riscontro nella realtà dei fatti. Non vi è episodio, per quanto banale e insignificante, dalla scritta murale al lancio di uova e ortaggi, che i media e le forze politiche tutte non dichiarassero messaggero di un imminente ritorno del terrorismo, la bestia nera degli anni Settanta. L’assenza di una inclinazione significativamente violenta del conflitto sociale creava, per così dire, una sorta di disorientamento, di vuoto nel rapporto di potere tra governanti e governati, che i primi si sarebbero ingegnati a colmare con un notevole sforzo di fantasia, talvolta assecondato dal narcisismo di parte dei movimenti.
Da tutti i pulpiti istituzionali si incitava ossessivamente a “non sottovalutare”, a “non abbassare la guardia” e dunque a oliare e accrescere gli strumenti di controllo e di repressione in attesa di un nemico che stava affilando i coltelli in un’oscurità tanto fitta da non vedersene nemmeno l’ombra. Qualche plico esplosivo di provenienza “informale” (il che la dice lunga sulla consistenza e stabilità strategica dei bombaroli postali) non cambia in alcun modo il quadro di una situazione di conflittualità sociale tenuta sostanzialmente entro solidi argini. Quanto alle parole che sarebbero diventate pallottole, neanche le menti più labili sono mai riuscite a prendere sul serio i truculenti proclami dei guerrieri padani e di altri commedianti di diverso orientamento. Così, a una pedagogia di Stato che trasformava temperini in scimitarre e vetrine sfasciate e cassonetti incendiati nel reato di “saccheggio e devastazione”, con relative mostruose pene detentive, (povero Attila surclassato da tifosi e manifestanti turbolenti) si accompagnava una totale censura sulla questione della violenza in termini politici, storici, sociologici o filosofici. L’interrogazione stessa sulle cause della violenza veniva interpretata come una sostanziale complicità con chi la esercitava.
All’origine di tutto questo la guerra senza quartiere condotta negli anni Ottanta, a partire dagli Stati Uniti, contro le analisi sociologiche del crimine al grido di “non è la società, sono i criminali i soli responsabili del crimine”. Parola d’ordine che, transitando agevolmente dalla criminologia alla politica, si adattava perfettamente tanto alla tradizione puritana d’oltre Atlantico quanto alla crisi fiscale dello Stato e che avrebbe ispirato, dilagando per ogni dove, la teoria e la pratica della “tolleranza zero”, con un vasto dispiego di violenza poliziesca e giudiziaria, accompagnata dal massiccio taglio delle politiche sociali.
I bastoni, si sa, sono sempre inversamente proporzionali alle carote e assai meno dispendiosi. Quanto al pensiero di una dimensione politica della violenza che istituisca o destabilizzi assetti e rapporti di forza, che incida in qualche modo sulla trasformazione della società, qualunque tentativo di accostarsi anche prudentemente al tema veniva sdegnosamente respinto come un rigurgito del “secolo del male”, il Novecento, sintomo di arretratezza e di incomprensione della immensa forza trasformatrice della non violenza, da una parte, e con la sacralizzazione della legalità e l’insostituibilità dei principi liberisti dall’altra.
Questo clima di interdizione e di censura comincia, tuttavia, a mostrare qualche crepa. I grandi movimenti pacifici, di opinione o di lotta poco importa, non hanno avuto consistenti risultati da esibire nel primo decennio del nuovo secolo, fatta eccezione per qualche dote profetica di cui compiacersi, l’asimmetria crescente tra poteri forti e soggetti indeboliti non ha indotto alcun ripensamento, gli strumenti di ricatto e di controllo sulla forza lavoro precaria non si sono accresciuti e inaspriti e la violenza degli Stati e dei mercati non incontra più nessun argine. Si fa allora strada l’idea che questa vocazione giurata alla non violenza non sia concretamente in grado di contrastare l’arbitrio del potere e la sua arroganza, che l’asimmetria (come scelta non come circostanza storica) non sia propriamente una virtù. Molti indizi rivelano che l’autopercezione vittimaria, la reazione trattenuta, rinviata o delegata all’intervento di un potere salvifico, fosse anche il mito della società civile o la riscossa giudiziaria, finiscono coll’alimentare, nella forma classica del ressentiment, populismi, nazionalismi e politiche identitarie. L’idea della violenza combinata con quella della delega, posta alle origini dello Stato moderno, contiene in sé tutti i veleni rinunciatari e subalterni distillati dal risentimento. Il quale nella deriva autoritaria delle democrazie contemporanee si rivela assai più potente della paura o dell’insicurezza che la dottrina poneva alle origini del contratto sociale.
Ed è proprio a partire dalla rottura di questo contratto e dall’esaurirsi della sua secolare narrazione, che Luisa Muraro, ripropone coraggiosamente in un recentissimo saggio (Dio è violent, Nottetempo) il tema della violenza al dibattito pubblico. Il ritorno della guerra come arbitrio regolatore dei rapporti internazionali, lo svuotarsi di quella promessa di progresso che aveva determinato la tenuta del contratto sociale moderno e il numero crescente degli esclusi dai suoi benefici, legittimano i contraenti a revocare la propria adesione. E a questo punto, di fronte a un potere con cui si è reciso il filo della delega e della rappresentanza, che si è sottratto o ci ha escluso dal contratto sociale, non ha senso presentarsi spogli di ogni forza o privi della consapevolezza che ogni esercizio della forza non può non contemplare lo sconfinamento nella violenza.
Qualche istantanea tratta dal mondo della grande crisi può introdurci a un altro modo, forse ancora più radicale, di guardare alla fine del contratto sociale e all’ipocrisia dei continui appelli perché tutti “facciano la loro parte” nel salvare il Paese, l’Europa, l’euro o addirittura l’economia planetaria. Distinti signori che rovistano nei cassonetti, famiglie sfrattate accampate in automobile, malati condannati a morte da un tracollo finanziario, licenziati arrampicati per ogni dove nella speranza di rendere almeno visibile la propria sorte, artigiani e piccoli imprenditori suicidi per debiti.
Sono i numerosi fuoriusciti dal basso dal contratto sociale. Ma quelli che contano di più, e determinano a proprio arbitrio la vita di tutti, sono i fuoriusciti dall’alto: i fondi d’investimento, le élite finanziarie, i banchieri, i cosiddetti mercati, il cui millantato automatismo maschera soggetti e ideologie, cultura e volontà di potenza che scorazzano in piena libertà nello spazio e nel tempo dell’economia globale. Impongono condizioni e non scendono a patti con nessuno, non vi è regola che non abbiano dato a sé stessi, non vi è giurisdizione o governo in grado di intaccarne gli interessi e contrastarne lo strapotere e la pervasività. Gli armatori greci, seconda industria del Paese, 16 per cento della flotta mondiale, hanno garantita per legge la detassazione degli immensi profitti accumulati in acque globali e dispongono di formidabili armi di ricatto che non hanno mancato di agitare quando Syriza minacciava di vincere le elezioni e abolire il privilegio. Ma ad Atene sono i pensionati, i salariati, i disoccupati a dover “fare la propria parte”, quelli che “hanno vissuto al di sopra dei propri mezzi”.
In breve, i poteri economici globali agiscono al di fuori da ogni contratto sociale o semplice compromesso, mentre il resto dell’umanità viene obbligato ad onorare il contratto stipulato, per via diretta o indiretta, pubblica o privata, con il capitale finanziario. Quanto più immateriali sono le fonti della rendita, tanto più materiali sono le condizioni imposte per garantirla. Ma perché mai un potere che agisce fuori dalla legge dei comuni mortali dovrebbe esserne protetto? Non dovrebbe forse essere la forza di una minaccia a determinare il rapporto tra gli esodati dal contratto sociale verso il basso e coloro che vi si sono sottratti dall’alto?
L’esclusione dalla comunità, dalla legalità e dalla sicurezza costituiva quella sorta di condanna a morte differita che, nell’antico diritto germanico, prendeva forma nella “messa al bando”e faceva del bandito la preda per eccellenza. Qui la sottrazione delle élite finanziarie al contratto sociale istituisce invece un potere predatore, che conserva tuttavia la prerogativa della sicurezza. La messa in questione di questa prerogativa è al centro di ogni ragionamento sulla violenza. Non si tratta di un impossibile ripristino del patto sociale, ma, al contrario, di rifiutare ogni obbedienza dovuta alla sua rappresentazione. Anche i messi al bando dallo stato sociale, i fuoriusciti dal basso, hanno tutte le ragioni di farsi “banditi” e tentare di raccogliere le forze per riappropriarsi della ricchezza sottratta. Da prede possono sempre farsi predatori. Chiamiamola pure senza timore guerriglia di classe.
Gli ottimisti di epoca paleo liberale profetizzavano che gli affari avrebbero sostituito le guerre. Non è andata proprio così, anche se, all’apparenza, la guerra fredda è stata vinta con le armi della competizione economica (che comprendeva comunque diverse guerre guerreggiate nonché il cosiddetto equilibrio del terrore e i suoi costi spropositati), con un enorme dispiegamento di violenza, il cui risultato, fra altri, è il regno di Putin e un discreto numero di orrende Satrapie. Fatto sta che nel mondo contemporaneo nessuna distinzione è più possibile tra violenza economica e violenza fisica e politica, tra quale sia venuta prima e quale sia venuta dopo, quale il mezzo e quale il fine, questione che fu al centro della lontana polemica tra Engels e Duehring. Quest’ultimo sosteneva che all’origine della nostra storia vi è un atto violento di asservimento dal quale i rapporti economici sarebbero poi discesi (per spiegarcelo il professore ricorre a Robinson e Venerdì), mentre Engels sosteneva il contrario, e cioè che l’asservimento politico non era che una funzione strumentale dei rapporti economici che precedono come premessa e seguono come risultato l’esercizio della violenza. La quale non ha svolto alcun ruolo nell’istituzione della proprietà privata. Mentre per Duehring la violenza si presentava dunque come un male assoluto ad esclusivo uso del potere e a fondamento di un ordine sociale iniquo (cosa che non pochi continuano a pensare), Engels si lasciava aperta la strada ad un uso rivoluzionario della violenza, chiamata a sovvertire quell’ordine iniquo, liberando quanto si era prodotto nel suo grembo.
Il fatto è che la violenza non è né un atto fondativo, né un mezzo, né la teleologica “levatrice della storia”( più intrigante sarebbe chiedersi se non sia ciò che tutti escludono e cioè un fine) ma una relazione in buona misura indipendente dalla coscienza, dalla scelta e dalla definizione teorica dei soggetti che vi sono coinvolti. Se vogliamo è un linguaggio che, per il solo fatto di essere inteso anche da chi non lo vuole parlare, pur disponendo degli strumenti per farlo, determina profondamente l’instaurazione, la natura e l’intensità del rapporto. Un ambiente, insomma, entro cui è necessario orientarsi e che non può essere cancellato con un atto di volontà. Il diritto stesso, con l’ammissione della legittima difesa, autorizza l’uso privato della violenza in un determinato contesto relazionale. E’ propriamente questo aspetto di relazione quello che la dottrina della non violenza non riesce a percepire e i corifei della legalità repressiva si sforzano di occultare. Ed è ancora questa natura relazionale che ostacola, come numerose esperienze storiche testimoniano, quella ricerca di una giusta misura nell’impiego della forza/violenza a cui Muraro invita. In questo misconoscimento sta anche quella concezione identitaria cui dobbiamo l’ invenzione dei “violenti” per vocazione e le interpretazioni più fantasiose del black bloc, un fenomeno radicato, non in una qualsivoglia dottrina o inclinazione, ma nella precarietà come forma di vita da cui consegue un vissuto “informale” della militanza.
La crisi mostra in altorilievo, nel cortocircuito immediato tra economia e violenza, la natura sopraffattrice dei rapporti sociali, e non più solo o essenzialmente per il dispositivo di sfruttamento che li sottende, ma per il governo diretto delle vite che la violenza economica esercita e in cui lo sfruttamento si articola. Laddove il braccio repressivo dello Stato non ha alcun bisogno di intervenire. E il termine stesso “violenza” è bandito. Nessuno annovererebbe tra le morti violente, la morte di qualcuno privo o privato dei mezzi per farsi curare dalla perdita di un lavoro o di una polizza. Nessuno ha mai fatto il conto di quante esistenze vengano quotidianamente annientate, con fredda cognizione di causa, per garantire la rendita dei capitali finanziari, i profitti dell’industria chimica o farmaceutica e perfino quelli della proprietà intellettuale. Si parlerà di iniquità, di ingiustizia, di inefficienza, perfino di reati, ma molto difficilmente di violenza. Se la narrazione del contratto sociale volge al termine, quella del contratto tra debitori e creditori gode di ottima salute e ne ha preso il posto come garanzia che il mondo civile non esca dai suoi cardini. L’indebitamento, in quanto servitù volontaria, è esentato da ogni riferimento alla violenza. Il tabù è decisivo, la distinzione irrinunciabile. Se infatti fossero identificate come violenza la privazione e lo strangolamento economico di soggetti deboli o indeboliti, di intere società, si riconoscerebbe una sorta di ius resistantiae, un diritto di opporsi con l’uso della forza agli atti che minacciano le nostre condizioni di esistenza. Lo sfrattato di Karlsruhe che ha accolto a fucilate il fabbro e l’ufficiale giudiziario troverebbe un suo posto nella storia della resistenza sociale, come lo ha trovato il ragazzo tunisino datosi alle fiamme, esasperato da un arbitrio di polizia, innescando con il suo gesto le rivolte arabe. Per questo il concetto stesso di violenza economica e l’idea che il potere del denaro possa costringere e assoggettare, come qualsiasi altra forma di violenza fisica, politica e non, devono essere banditi a ogni costo. Chi dovesse infrangere questo divieto sarebbe subito accusato di ideologia, di non riconoscere l’ “oggettività” delle leggi di mercato e infine di essere un nostalgico della novecentesca lotta di classe. E non è certo il caso di prendersela a male
E, tuttavia, l’inasprirsi della crisi ha cominciato a sdoganare il concetto di violenza economica e l’idea che ad essa potesse opporsi una violenza sociale che, almeno simbolicamente, ne aggredisse i dispositivi, i linguaggi, i dogmi. La Grecia è stata per un tempo interminabile teatro di scontri violenti e guerriglia urbana, i minatori spagnoli hanno catalizzato la rabbia dei cittadini di Madrid, le rivolte metropolitane si sono moltiplicate in Europa e in America, e in certi momenti gli uomini della City o di Wall Street hanno dovuto strisciare lungo i muri mimetizzati da anonimi cittadini. Ma di queste insorgenze c’è da dire che non hanno conseguito maggiori risultati dei grandi movimenti ispirati alla non violenza. Non sono state considerate una minaccia abbastanza seria da doverci venire a patti. Il campanello di allarme non ha suonato abbastanza forte e la catena di corruzione, condizionamenti e ricatti che dalle élite sovranazionali discende ai governi nazionali, fino al pallido spettro delle forze politiche e delle loro clientele (soprattutto quelle dell’Europa mediterranea) ha sostanzialmente tenuto.
Poteri grandi e piccoli si sentono relativamente al sicuro. E tuttavia il tabù è seriamente incrinato, il contenuto di violenza insito nei rapporti sociali si è fatto sempre più evidente e l’esperienza dell’ingiustizia si è estesa a livello di massa, così come il suo rifiuto. Tanto impotente resta, però, una violenza senza forza, quanto una forza troppo trattenuta dal tabù della violenza, illusa di potersi sottrarre, nel suo autismo etico, alla relazione violenta che ci sta schiacciando, mentre dovremmo, invece, trovare l’efficacia necessaria per affrontarla. Se possibile, con misura. Altrimenti, dovremo farlo in ogni caso.